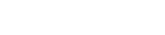Entrare nel tempo e nello spazio di un lavoro artistico è sempre un’operazione complessa che induce ad una sorta di auto analisi della capacità di rimanere in un campo identitario e non farsi disseminare, di qua e di là, perdendosi nella vaporosa essenzialità della contemplazione. Si tratta, quindi, di mantenere un equilibrio che permetta di filtrare la molteplicità di suggestioni che vengono da un universo visivo tempestato da una effusività che non si placa, quando, invece, non accelera e rende imprevedibili le sue giravolte, accomodandosi in maniera, direi, psicologica, ora con sensuale piacevolezza, ora con nervosa ricchezza.
Essere dotati di un ampio ornamentario linguistico e concettuale è necessario, in quanto istituisce la possibilità di un codice, con cui penetrare nell’oggettività enigmatica delle opere e farsene interprete, con tutte quelle ossessività dialettiche che ne derivano. L’atmosfera è catturante, avvolgente, con tutte le incertezze di un dire che non è, non può, essere lineare, ma deve costruirsi entrando dentro lo specchio frammentato, che non solo gli si para davanti, condizionandone il cammino e le soste, ma si veste con gli abiti del labirinto per fare impazzire i ragionamenti e renderli autoreferenti. La scrittura e il pensiero della sua percorribilità si trova, dunque, nella mancanza di un pericolo che può portare all’insignificanza, ad un grado zero della sua distinguibilità dal silenzio, che va affrontato, con la forza del suono inudibile del pensiero, nella sua fase laboratoriale e segreta, quando si pone in meditazione e in posizione di verifica della sua stessa soggettività, perché non si tratta di lasciarsi dondolare e addormentare, ma di estrarne una visibilità con cui fare i conti, in termini di una spazialità che è architettura arcana sia quando si ispira alle sublimità di un paesaggio dell’anima, sia quando deriva dalla bellezza di una architettualità in fieri.
Sono le tramature di un saper vedere che non può accontentarsi di una simbologia usata e abusata, ma deve spingersi, mossa da un forte impulso interiore, a scandagliare le differenze che si annidano nelle analogie, quando gli effetti visivi sembrano ripetersi e sfoggiano spostamenti molecolari, invisibili all’occhio nudo di cognizioni antropologiche, psicologiche, ma anche le analogie ingannevoli che stanno nell’eclatanza delle differenze. È proprio questo il percorso della critica, tra emozione e filologia, tra genealogia dell’immaginario e rivoluzione dei gesti, quando si configura un articolato intrecciarsi di teoria della prassi e di linguaggio della follia, senza di cui non c’è arte, ma solo filo della decorazione, sensibilità di effetti visivi, alle cui spalle c’è la cavernosità tragica del nulla. Per cui tra queste tensioni visive, che sono mimesis di paesaggio reale e di finzioni fantastiche, mi sembra che subentrino, potentemente, delle alkimie che ambiscano ad una trasformazione qualitativa di questo guardare fuori, alla stessa maniera del guardarsi dentro e di questo guardarsi dentro con le immagini postume di un abbaglio solare. E non è un caso che ne vengano fuori delle geographie che segnano un bisogno di oggettività su cui poggiare quel necessario senso comune, senza cui non c’è fantasia ma solo perdita e dissoluzione dell’io, per lanciarsi nella infinitezza delle soluzioni possibili al linguaggio aperto che porta con sé l’astrazione fino al delirio possibile, l’informale fino ad un suo possibile rovesciarsi nella riconoscibilità e nella consuetudine per cui basta l’intuizione e l’invisibilità, per darsi un nome e un cognome.
Melchiorre Napolitano dipinge l’alterego della sua stessa vita, in un grande diario in pubblico che crea un essere parallelo che risponde ad una sua precisa sintassi babelica, presentandosi a noi nelle forme e nei colori che sono il frutto di lunghi inverni di gestazione e meravigliose primavere di fioritura, connotando cromatologie che sono, ogni volta, apparizioni d’ignoto.
Il colore è, appunto, uno dei maggiori momenti dell’impegno pittorico, visto anche che tutto questo lavoro si svolge sul versante tonalistico e che il momento plastico è vissuto come un appendice che tende a sottolinearne il movimento, la deriva, la magmaticità, vorrei dire, di una entità che non si trova mai ad essere fissa e statica, ma percorre sempre una spazialità sua propria, da cui non può prescindere. In questa tipologia di scorrimento, si viene a situare la sua originalità, che a volte rasenta la commozione emotiva, mentre a volte sembra connotare una fredda oggettività, anche se c’è sempre un punto di fuga dai due apporti e paradossali esiti, da cui ora, che siamo situati in un punto d’osservazione molto privilegiato, attuale, si può vedere tanto se non tutto e quindi darsi una ragione di tutta la dinamica trasversale, di cui è nascosta l’essenza, gelosamente nascosta, in quanto motore immobile di tutto, per rendere più interessante la fenomenica delle opere da cui non si può prescindere in una poetica dello sguardo, di cui si è impadronito bene Franco Solmi, quando ha scritto che “iconograficamente le opere ci restituiscono visioni atmosferiche, di paesaggio dolcemente sconvolto, quali avrebbe potuto immaginarle Turner. In effetti Melchiorre Napolitano dipinge metafore ed allegorie, misteri laici che richiedono, una predisposizione lirica ad essere interpretati. Forte è infatti il suo accento sui valori pittorici che non possono non essere che valori di luce, momenti e insiemi ineludibili. È la via più difficile, ma anche la più suggestiva, per raggiungere attraverso l’immaginario, gli strati profondi dell’emozione che supera e insieme comprende la realtà.
Insistita e ripetitiva ma mai uguale a se stessa, infatti l’immagine si fa così raccolta, essenziale implacabile, lirica. Vi si realizza a livello di raggiunta espressività, l’impegno più elevato dell’artista (...)”. L’individuazione di questa scalarità di toni che vanno dall’alto di una metafisica dell’imprendibile, in senso totale, al basso di una fisica del palpabile e del tangibile, ma non per questo più comprensibile nell’ambito di una manifestazione del realistico, serve comunque a trovare la molteplicità di punti di osservazione, ognuno dei quali dà una faccia diversa, per cui ogni senso di unità viene emulsionato da reazioni meccaniche o alchemiche, fancendo sì che si perda la nozione di alto e di basso e si ritrovi un ordine sui generis che molti potrebbero leggere come un disordine, ma in effetti è un tertium che non è, né della realtà, né dell’irrealtà, ma è della fantasia quando viene ad impattare i problemi della forma, sia in tutte quelle declinazioni note, che chiamiamo ordinarie, sia in tutte quelle altre, che sfidano la nostra esigenza nomenclare e osservativa, che chiamiamo straordinarie.
In effetti, Melchiorre Napolitano, non pensa mai d’abbandonare la forma, solo che ne percorre le contrade impervie che sfidano le opposte sponde della realtà e dell’irrealtà, per esplorare una sorta di terra di nessuno, in cui non c’è segnaletica e direzionalità ed ogni accadere deve sfidare il senso di solitudine che è tipico di ogni ricerca quando si innamora di se stessa ed entra in una intensa fase narcisica, che è totalmente energetica, come ha notato Salvatore Maugeri, nello scrivere che nelle intermittenze in cui sembra che si riconosca qualche tratto, ascrivibile ad una formalità condivisa “non si tratta tuttavia di frammenti di realtà, ma di inquieti regni vitali, che ne cercano altri con i quali coordinarsi, come se dovessero trascorrere una fase di sensazioni precise al loro successivo sciogliersi e riaddensarsi per effetto e in conseguenza di una spinta prodotta da imperiosa fantasia. Una fantasia che riesce a trovare il suo alimento in un senso religioso della natura”. Ciò sembra a Maugeri, poter essere ontologico di un equivoco, ma non di equivoco si tratta, bensì di un intenso rischio poliscenico, che è il vero rischio che l’arte non solo si possa permettere, ma che si deve permettere, pena il suo dissolversi.
In sostanza, non si tratta mai di un universo stabile, con cui istituire un dialogo, anche in condizioni difficili, in cui la stessa parola stenta a definirsi, figurarsi un contesto di significati, organicamente inseriti come insignificanti, anche perché esistono alcuni punti critici, che connotano lo stesso artista come un velatore, che vuole tenere l’elegia e lo sguardo in uno spazio neutro, in una sospensione che ne acuisca la tensione e l’attragga ineluttabilmente nel fascino degli interrogativi a cascata su un possibile essere e non essere, come versioni ultime di una dialettica tra visibile e invisibile. Ritrovandosi, in ciò, con tanti e con nessuno, tanto da fare parlare di forme fragili, pronte a rompersi, perdersi, dissolversi, anche se non bisogna farsi ingannare da questa affermazione che non redige uno statuto di cagionevolezza e di pericolo, quanto l’ergersi di una sfida della crisi agli svuotamenti progressivi a cui tutti noi siamo esposti fra il fatto di esistere in questa condizione postmoderna, che da Jean François Lyotard in poi è entrata nel brand delle nostre affermazioni che si chiamano astrazione e informale, che vengono dal cuore della modernità, ma sono antidoti allo schiacciamento che il disordine e l’entropia possono determinare con il sorgere di un linguaggio che è un esplorazione esteriore ed interiore, appoggiata ad una storia, che è personale, fatta di predilezioni e di ossessioni, ma è anche una catena poietica che viene da lontano, che ha subito tante mutazioni, alcune eclatanti e rivoluzionarie, implicandosi con il linguaggio della follia, con quello del disagio ambientale, con gli sperimentalismi, annettendosi questioni culturologiche che coinvolgono tutta la civiltà delle immagini sulla scia della scomposizione cubista e futurista da Braque e Boccioni, passando per l’offuscamento di ogni naturalismo, per l’indagine mentale surrealista e per tutte quelle energetiche gestualità che sono più da pratiche psicanalitiche che da critica, o da semplice discorso, sull’arte; ma in fondo la pittura non è stata mai una pratica serena della tecnica, per tali e tanti sconfinamenti nel rito, nella religione, nella catarsi, nell’autoanalisi. Faccio mia, un’intensa citazione con cui Gert Eilemberger, scienziato ed epistemologo, definisce il nostro senso della bellezza, nel tratto linguistico ambiguo che comprende anche la sublimità, come due aspetti estremi di una misura e dismisura entro cui si situa “la combinazione armonica di ordine e disordine, quale si presenta negli oggetti naturali: nuvole, alberi, catene di montagne o cristalli di neve. Le forme di tutti questi oggetti sono processi dinamici consolidati in forme fisiche e particolari combinazioni di ordine e disordine sono tipiche di tali forme”, solo che questa tipicità è sfuggente, per cui la mettiamo fuori di noi, ma rimaniamo con un vuoto dentro.
Come a dire che non può esistere nulla, che in assoluto non abbia una forma, solo che noi tendiamo a circoscrivere, questo ambito e siamo disposti ad ampliarne i confini con molta cautela, a meno che non vengano ad esprimersi dei catalizzatori che si chiamano scoperte scientifiche e opere d’arte, le une frutto di svelamento, le altre d’invenzione, con due processi oppositivi che fanno riferimento l’uno alla ragione e alla matematica e l’altro all’intuizione e alla fantasia, ma che vengono paradossalmente a incontrarsi nella sintesi tra il piccolo e il grande, tra il semplice e il complesso, come ha ben compreso Marcello Venturoli, quando ha scritto a proposito del rapporto tra quanto l’artista fa e quali mezzi utilizza. Così assoscrive: “Forse l’artista suona la sua sinfonia su un filo d’erba, forse le sue pagine potrebbero o dovrebbero assumere una dimensione vasta, creare iperboli grandeggianti di spazi visitati dalla luce, suo grande motore e regista, assumere maggiore arroganza. Ma questa è una realtà non attuale dell’artista, che dipinge e sogna come un uomo d’oggi per dovere di fuga, che ci è molto cara e che non vorrei proprio che vi rinunciasse, né tanto né poco”, magari inseguendo una prospettiva concettuale che lo portasse a un minimalismo da grado zero o ad accentuare la costruzione mimetica delle immagini.
Transitare su tematiche diverse vuol dire affidare il proprio estro ad una necessità d’invenzione continua, che è tanto più necessaria, quanto più il cerchio tende a restringersi su alcuni punti focali che sono assorbenti per ciascuno di noi, che non sono fissazioni in senso patologico, anche se possono divenirlo, tanto che l’arte, le opere, queste opere, possono operare in senso salutare, facendo da terapia dell’insoddisfazione, che è il motore di ogni evento, fantastico o reale che sia, perché è da quel momento, da quel tichettio che tutto si origina come poetica del frammento, di un dopo Babele che tende a riprendersi, a ricostruirsi dalla botta subita e procedere per una nuova utopia.
Si allerta così la memoria, la sua personale e la nostra, a cui ogni suggestione visiva, regala non solo un’emozione, ma anche la messa in moto di un tempo rovesciato, con cui si vengono a creare delle associazioni mentali che poi non si fermano più, conducendo il pensiero in meandri sperduti e in grandi agorà, ma anche in grovigli e slittamenti progressvi. Si avvertono delle allucinazioni oniriche, che sono le uniche localizzazioni dove tutto questo possa accadere senza degenerare in una catastrofe di autoreferenzialità e di autismo segnico, in opposizione all’intento dell’artista che è quello di forzare i sigilli ermetici e passare oltre, anche a costo di scoprire che lo spessore non è altro, rispetto all’effetto di ridondanza, che rimanda il qui ed ora, come in un doppio specchio che simula le fattezze dell’infinito.
Come infinito è questo modo di procedere che è inarrestabile, se non per la stanchezza fisica che non può tenere testa al circuito mediatico individuale che produce opere, con una meccanica di trasformazione tutta speciale, tra quello che tanti fanno e quello che pochi fanno, avvertendo la tensione del fare come una crisi in senso evolutivo, ma soprattutto creativo, per quell’input che porta alle soglie del nulla, antropologicamente incomprensibile, per poi salire in anabasi. Genny Di Bert, in un suo significativo testo, definisce il lavoro di questi anni in termini di grande leggerezza e sensualità, riconoscendo in esso un’ampia escursione impressiva, che lo rende molto interessante e stimolante, parlando quasi di una devozione a modelli matematici, in termini di formule-quadri con una forte carica immaginativa. “Si tratta a volte (scrive) di una proposta di formule gestuali pur sempre singolari nella loro nonripetitività, che dona alle immagini un “progresso” incontestabile della matericità. In questo contesto, la luminosità crea una particolare sonorità espressiva, la luce produce, inoltre, delle velate linee di demarcazione fra i vari soggetti. I modelli delle cose dipinte sembrano scie di un flash ottico arrivato e passato velocemente..., nulla è riflesso e tutti gli elementi sembrano privi di gravità”. Compresi quelli che appartengono alla sua vocazione plastica oggettiva e architettonica, che si rapportano con le nicchie di spazio delle interiorità e delle concavità e con la sagomatura esterna in cui sono le trasversalità a tenere banco, a creare il vero e proprio tessuto della virtualità.
I molteplici rapporti di spazio e di tempo, che appartengono al nostro senso comune, illuminano le ascendenze lontane di un William Turner, ma anche quelle più prossime di Jean Dubuffet e di Jean Fautrier, nel senso di arricchire il portafoglio delle sue partecipazioni che lo mettono nella duplice scenografia di continuità e discontinuità, che da un lato lo allacciano alla storia di un linguaggio e dall’altro lo liberano in tutta la sua istintuale volontà di espressione e rappresentazione, portandolo alla nostra attenzione in senso lungo e largo, come si conviene ad un lavoro che non è condanna, ma infinita passione.